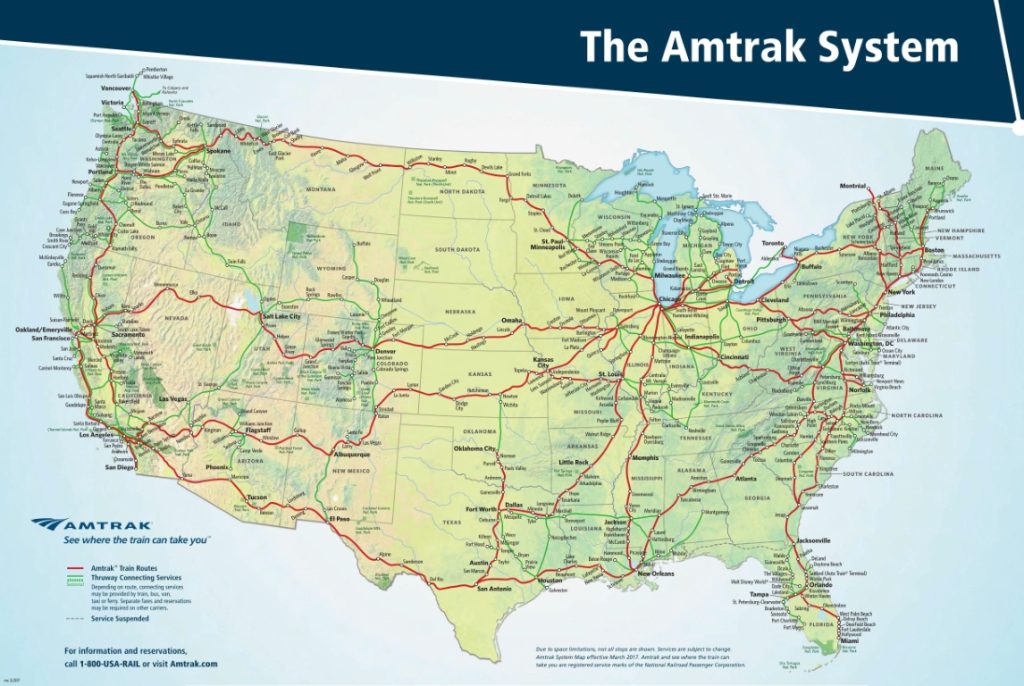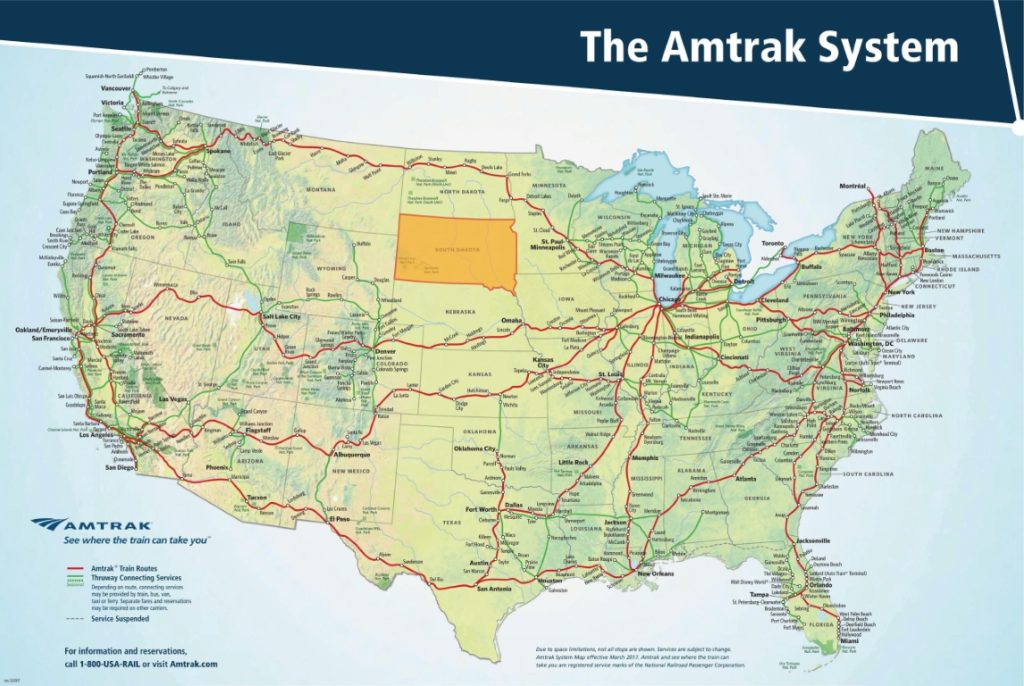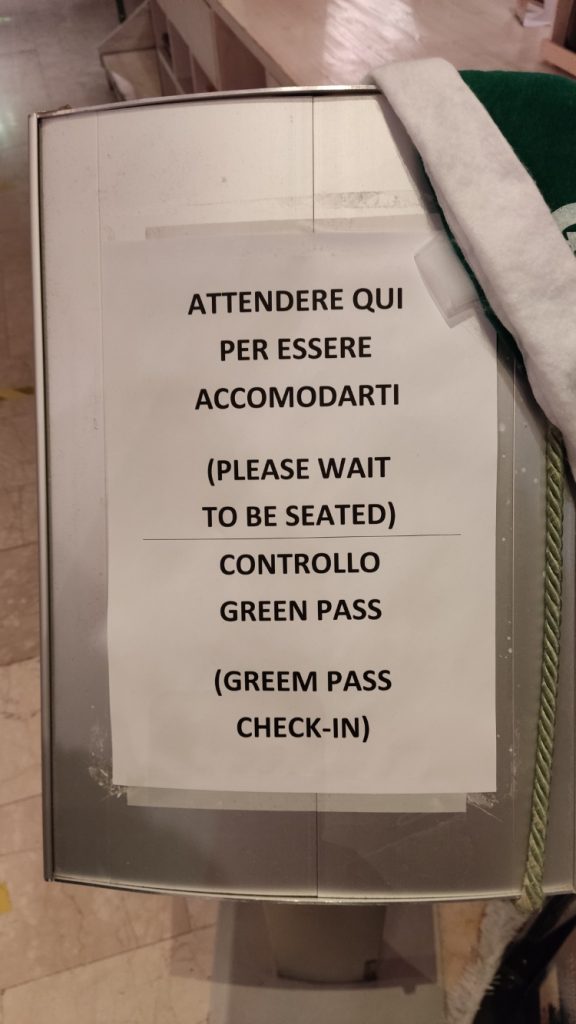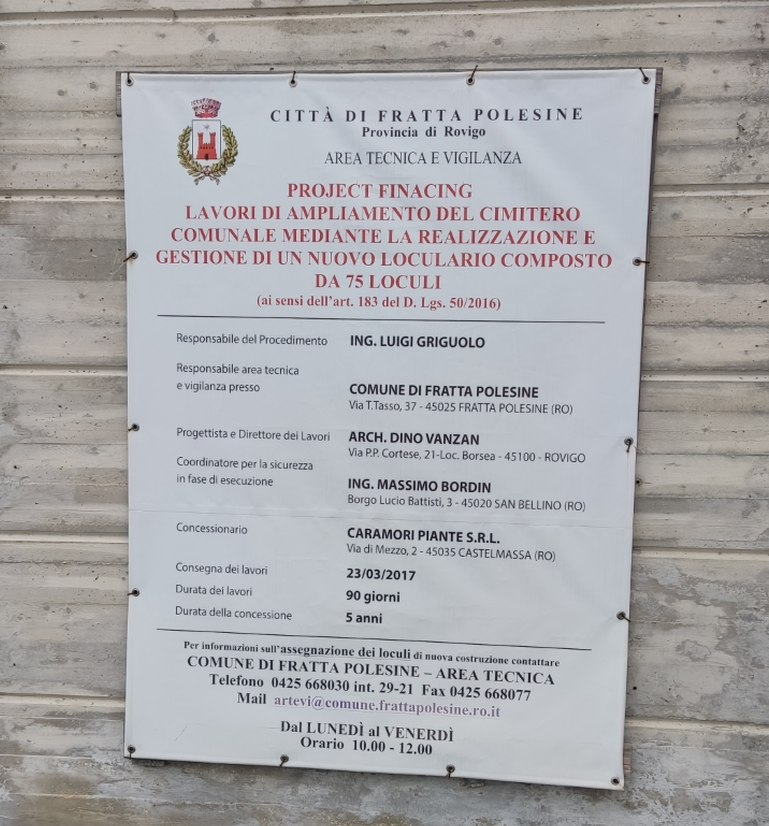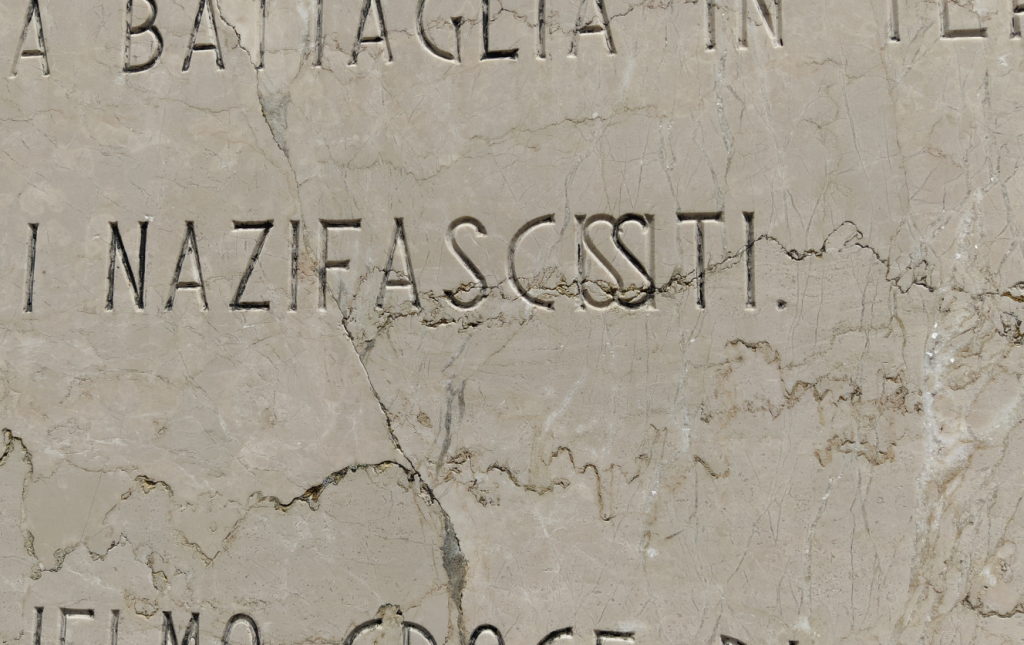La colazione nel bow window della casa georgiana che mi fa da albergo è memorabile. Non per il cibo, mi sono accontentato di due onesti toast col loro maledetto burro salato, non posso evidentemente sopravvivere a una full english al giorno, quanto per il contesto: fuori piove e volano le foglie gialle d’autunno, davanti a me scorre il Tamigi che sebbene qui sia largo sì e no cinque metri è bello impetuoso, il padrone di casa ha chiesto per favore ad Alexa di mettere della musica e lei ha messo Otis Redding, beh, dentro fa caldino e tutto va bene, non ho tanta voglia di raccattare le mie cose e ripartire.
Se però mi fermassi, tra mezz’ora mi romperei le balle, mi conosco, è la mia condanna e la mia fortuna, mi tocca rimettermi sempre in moto. E poi fuori a sguazzar alle intemperie sto meglio. Centonovantaduesimo giorno consecutivo di pioggia, ieri non appena sono arrivato a Oxford ho incontrato senz’altro la figura più ragguardevole in città, un tipo vestito da cazzo. Non vestito male, intendo vestito proprio da pene. Riconoscendo evidentemente la statura paragonabile del proprio interlocutore, mi ha chiesto un autografo. Ecco, questo per iniziare in bellezza, posso cadaunare foto a chi mi scrive. D’altronde Oxford è pur sempre un grosso campus in cui i collegi sono edifici in pietra gialla del quattordicesimo secolo abitati però da studenti. A parte un certo odore di marijuana persistente e, appunto, qualche bislacco vestito, non vedo intemperanze significative, sono tanto carini. Io sono qui per vedere la città e soprattutto la biblioteca bodleiana, paragonabile senz’altro per vetustà e dotazione alle nostre malatestiana e laurenziana. Al re, dico Giacomo I a memoria e ci starebbe, che ai primi del Seicento chiedeva dei testi in prestito, la biblioteca rispose in modo estremamente british che avrebbe potuto tranquillamente venire a consultarli in sala esattamente come tutti gli altri. E quello venne. Certo, poi gli fecero uno stallo chiuso tutto per lui che ancora si vede ma ciò non toglie una virgola al succo della storia.

A proposito di re, ieri c’è stato il discorso di re Carlo, terzo stavolta, che ha suscitato interesse in molti paesi del mondo per il fatto che il re, come di consueto, legge un discorso scritto dal primo ministro con le intenzioni di governo. E se fino a Elisabetta la cosa ha destato poco scalpore perché lei avrebbe potuto leggere il bugiardino del Voltaren senza fare una piega, non è nemmeno chiaro se abbia mai avuto un’opinione propria, ora Carlo ha dovuto sostenere iniziative chiaramente in contrasto con le sue convinzioni. La cosa non ha suscitato il minimo interesse qui, ci sono abituati e niente di nuovo, è un meccanismo interessante della monarchia parlamentare, piuttosto si sganasciano sull’aspetto dimesso della coppia, persino un po’ gobbetta.

Dell’altra storia che coinvolge le relazioni italo-inglesi poca roba. Riassumo: una sfortunata bambina inglese di otto mesi soffre di una rara malattia che le impedisce di sviluppare qualsiasi muscolo, malattia incurabile va detto, e l’Alta Corte inglese ha stabilito per lei, secondo legge, l’interruzione del supporto vitale. Si è inserito il governo italiano che in fretta e furia con un consiglio dei ministri d’urgenza ha dato alla bambina la cittadinanza italiana e richiede il trasferimento in ospedale romano, mentre Meloni fa la sua recita difendendo la vita a prescindere e alimentando le irragionevoli speranze dei genitori. Chiaro che queste cose è insensato farle decidere ai genitori, la legge serve appunto a questo, a stabilire un limite oltre il quale è bene non andare. Crudeltà, dico io, accanimento, i giornali inglesi si limitano a sottolineare le differenze culturali con gli italiani, in questo caso dovute alla matrice cattolica. Da parte mia, se devo scegliere, preferisco un governo che si assuma delle responsabilità decidendo che in certi casi o per età certi interventi non si fanno piuttosto che uno che mi condanni, me o altri, intendiamoci, a una vita al di sotto della qualità minima dignitosa in nome di convinzioni di stampo culturale e religioso. Amici che lavorano in ospedale mi raccontano di continuo di interventi a ultraottantenni che nel resto del mondo non ai sognano nemmeno di fare. Qui men che meno, tendono a essere molto pragmatici.

A un corso di marxismo in venti minuti; a una gita a Sutton Courtenay, amabile paesino qui vicino in cui è sepolto George Orwell, non però così vicino da andarci a piedi nonostante l’immensa ammirazione che ho per lo scrittore; a una visita a Blenheim palace, luogo di nascita di Churchill e mastodontico palazzo nella campagna inglese che appare in ogni film o serie tv quando si rappresenta un palazzo reale, che richiederebbe però una giornata; alla villa romana di North Leigh, anch’essa piuttosto distante senza auto; a queste succulente opzioni dicevo preferisco un’esperienza completa al pub, fatta come si deve. Quando fa buio e visto che piove, cioè verso le cinque e mezza, scelgo il The Grape in George St. e mi ci installo per le prossime ore. Le pareti sono tappezzate di vedute dipinte da rigattiere, potrebbero essere i venticinquemila quadri di Berlusconi, ma l’effetto è caldo e accogliente. In tv ci sono i mondiali, credo, di cricket, sport davvero appassionante, i posti sono occupati per metà e con alcuni degli occupanti ci siamo fatti un cenno di saluto e di intesa, scelgo il mio primo tipo di birra e mi metto comodo col libro.

Dalla seconda birra il barista, pubber?, mi chiama buddy, amico, perdio se ci sanno fare, loro fanno così e noi ci troviamo in un luogo confortevole e sosteniamo con vigore l’economia legata alla produzione alcolica. Dopo un centinaio di pagine e adeguato accompagnamento, l’atmosfera cambia, il cricket è finito, il barista mette sul giradischi, vero, i Kinks, il signore ti benedica, I think I’m sophisticated ‘cause I’m living my life / Like a good homo sapiens, il volume delle conversazioni si alza, il locale si riempie. Anche di donne, questa cosa è abbastanza recente. Bene in generale, meno quando le si trovano a gambe all’aria nel cassonetto qui fuori per eccesso di tasso. Oddio, questo vale per qualsiasi genere. Comunque, il locale si riempie ed è bello perché, cosa illegale in Italia, ci si può sedere anche allo stesso tavolo senza conoscersi e, anzi, chiacchierare. Così, so che sembra incredibile. Mi ricorda alcune scene da Cheers e, visto che io sono qui da prima, sono chiaramente Norm. Be glad there’s one place in the world / Where everybody knows your name / And they’re always glad you came. Poi si cambia di nuovo, sono circa a due ore e mezza di permanenza, alcuni corrono quarantacinque chilometri nello stesso tempo: si riaccende la tv, c’è una partita di calcio, alcuni vanno a casa – ma sono sicuro che per buona parte tornino – e qui si comincia a mangiare. Anzi, a ordinare, cibo e giusto accompagnamento. Io prendo delle salsicce del Cumberland con il purè e delle patatine che siccome non sono sbucciate si chiamano giustamente skin on fries. Tanto il mio nutrizionista è morto tre giorni fa. Poi quelli che hanno cenato a casa tornano, con alcuni nuovi, termina il fòbal e si rimette la musica e la serata prende il volo. Non per me, non per molto, che ormai ho l’aspetto dell’arredo e comunque sono in giro da quindici ore, piglio su le mie carabattole che domani mi muovo presto. E che meraviglia, in tre mi salutano, sono commosso. And they’re always glad you came. Se decidessi di vivere qui dovrei senz’altro dotarmi di storie da raccontare al pub, perfezionarle ed esercitarmi, si vede che sono un dilettante. Ciao a tutti, ci vediamo tra cinque anni, oppure in giro. State bene.