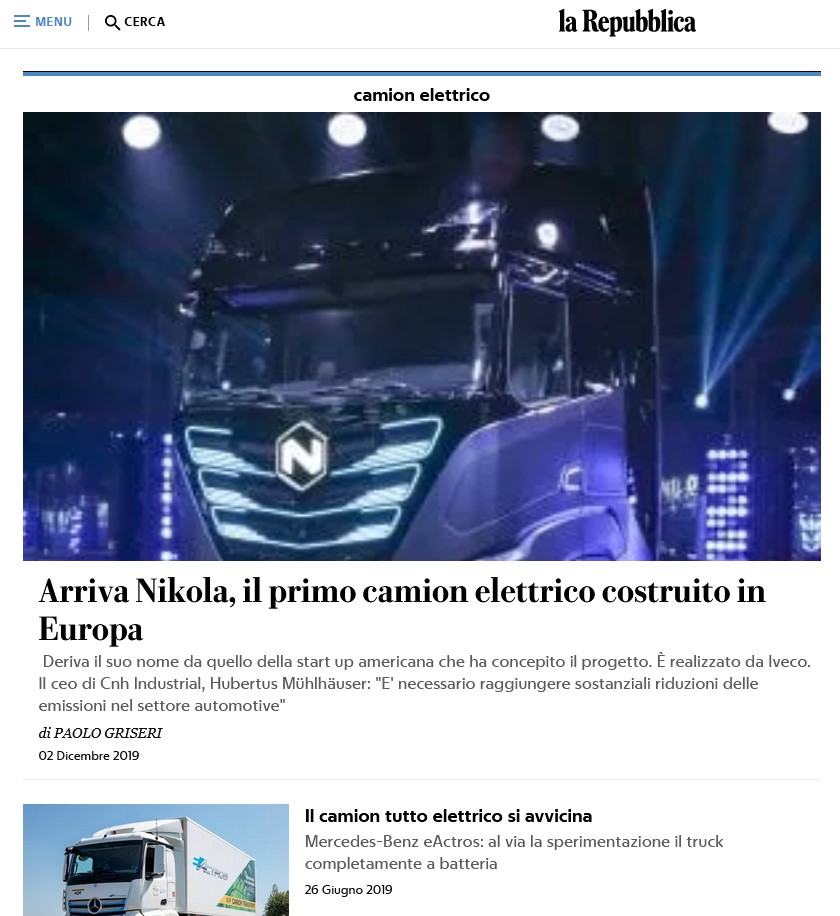Mi è sempre piaciuto, Gianluca Vialli. Fin dai tempi della Sampdoria, lo ricordo eccome, agganciava un lancio da trenta metri andandoselo a prendere, faceva altri quindici metri a sportellate con qualche difensore, poi guadagnava quel mezzo metro in velocità che gli permetteva di sparare in rete, spesso sul primo palo. Poi tutti a dire che il lancio illuminante era di Mancini, per carità, capitava, ma il grosso lo faceva lui. Ricciolo, simpatico, guascone, spesso irresistibile, era il nove di quel gruppone di giovinastri di Vicini, bravi. Alla Juve diventò capitano, più grosso e autorevole, sollevò la coppa per davvero, fece anche cose in acrobazia da ricordarsele. Poi andò in Inghilterra e lo perdemmo di vista, a un certo punto fece anche quella cosa stramba e tutta inglese del giocatore-allenatore. Mi è sempre piaciuto, Gianluca Vialli.
Ma non solo per il fòball. Mi è piaciuto perché quando si è ammalato non ha usato la retorica, idiota, del guerriero e della lotta, e sì che ne aveva anche la formazione, ma ha affrontato la malattia come si deve, con intelligenza, fatica e sofferenza, parlandone come di una compagna di viaggio da cui non ci si riesce a liberare e si può sperare di avere del tempo. La metafora della lotta è sciocca perché non aiuta e comporta moltissimi impliciti che peggiorano la comprensione del problema, Vialli era più intelligente e capace, ha rilasciato alcune interviste di grande saggezza e con approccio realista, consapevole ma mai abbandonato. Mi è sempre piaciuto, Gianluca Vialli. Molto come calciatore ma ancor più come persona.