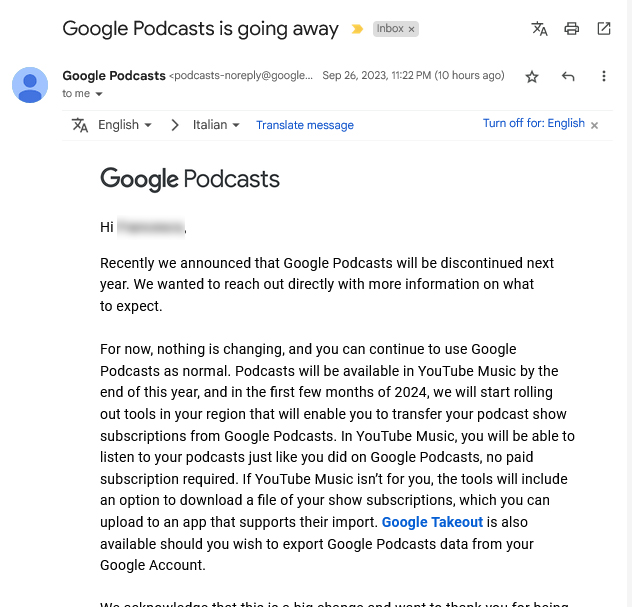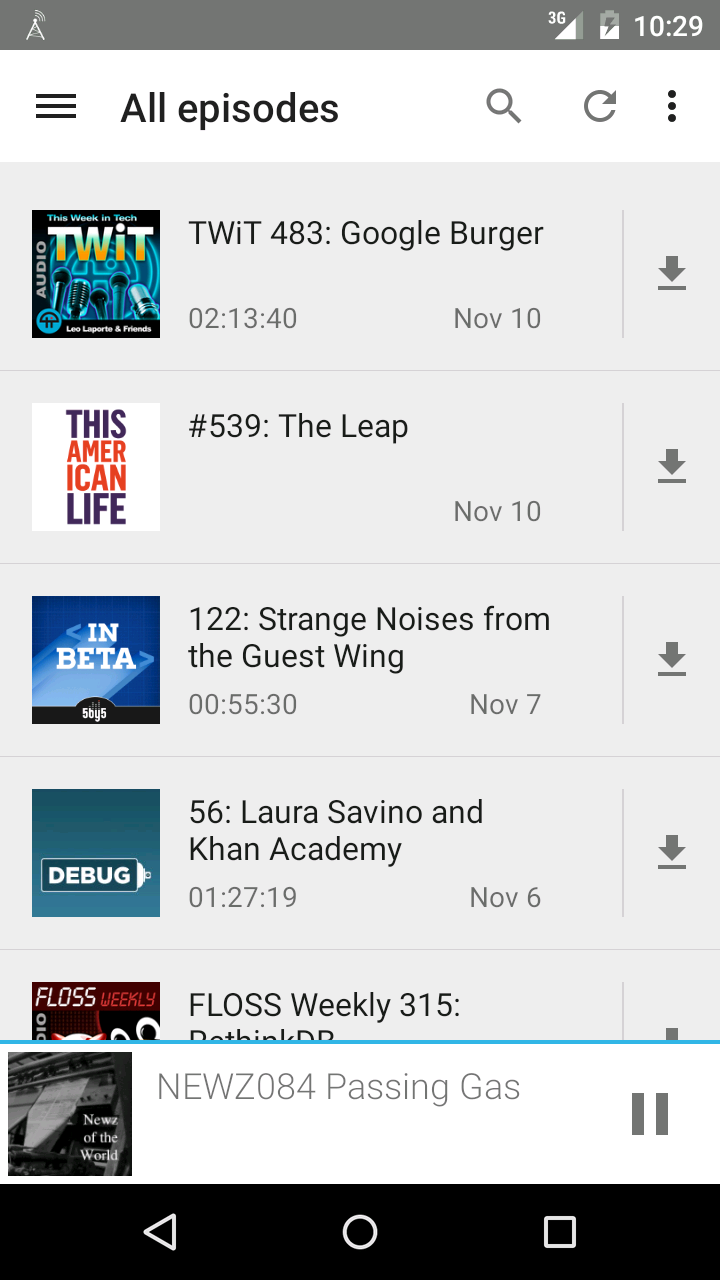E il motivo per cui sono a Manchester: Natalie Merchant dal vivo. Un teatrone di quelli, per capirci, tipo Ariston a Sanremo, con ventotto spillatrici di birra sul lato opposto al palco e bagni in ogni angolo. Che civiltà. Poiché avevo pochi anni adolescenti quando una ragazza mi parlò dei 10,000 maniacs alla fine degli anni Ottanta, direi di essere il più giovane in tutta la sala. Ma è questione di percezione, sono quasi tutti miei coetanei e penseranno lo stesso di sé stessi rispetto a me. Quando lei mi parlò della band eravamo in un minuscolo paesino dell’Essex e mi è parso significativo venire a sentire Merchant qui, di nuovo in Inghilterra. Ci avevo messo una pietra sopra visto che è una da un disco ogni otto anni e invece no, c’è stata un’occasione e l’ho colta. Salvo poi scoprire una settimana fa che tra dieci giorni sarà anche in Italia, comoda e vicina, che così sembro uno snob tremendo. Oddio, sembro… Comunque, per chi volesse consiglio senz’altro in ordine due suoi dischi solisti, Ophelia e Tigerlily, e uno con la band, In my tribe. Ma certo, anche il resto, questi però io uoah.

Certo che uno poi si chiede come accidenti abbiano fatto a mettere in piedi e tener su un impero mondiale se ancora hanno quella cosa ridicola dei due rubinetti sul lavandino, uno con acqua gelata e l’altro che proviene direttamente dal centro della terra e per miscelare bisogna ustionarsi e rapidamente lenire dall’altro, di continuo. E le stufette elettriche, le prese col timer meccanico, gli interruttori sopra le prese perché le condizioni del grande incendio di Londra del 1666 sono ancora le stesse e quell’aria perenne che si stia per rompere tutto. E le compagnie ferroviarie? Dodici. E ognuna che governa tratte diverse e richiede un account diverso e un sito diverso e un’app diversa, quando c’è e di solito no, e ci ho messo un po’ a capirlo, che io cercavo su Merseyrail e invece era Cross Country Trains. Ma quest’ultima è colpa della Thatcher, prima British railways c’era, maledetta anche stavolta. Avevo una maglietta che diceva I stll hate Thatcher, il sentimento resta.

Un mistero, questi inglesi. Bryson, che sto leggendo come dicevo due minidiari fa, dice una cosa buffa su di loro, ovvero che se il socialismo reale si fosse dispiegato non solo in Russia ma anche qui, tutto sommato non si sarebbero trovati male: “Tanto per cominciare sono persone cui piace fare senza. Sono bravissimi a rimanere uniti, specie di fronte alle sventure, per il bene della collettività. Stanno pazientemente in coda per un tempo infinito e accettano con straordinaria forza d’animo l’imposizione di razionamenti di cibo, pietanze scondite e carenze improvvise di beni di primaria necessità, come è noto a chi vada in cerca di pane il sabato pomeriggio in un supermercato. Sopportano bene la cieca burocrazia e, come ha dimostrato la signora Thatcher, sanno tollerare le dittature. Sono capaci di aspettare per anni e senza batter ciglio la consegna di un elettrodomestico. Hanno un talento naturale per le spiritosaggini sull’autorità, pur senza criticarla seriamente, e traggono generale soddisfazione di fronte al tracollo dei ricchi e dei potenti. La maggior parte di chi è al di sopra dei venticinque anni si veste già come i tedeschi dell’Est”.
Eheh. Andando in stazione, passo per il Gay Quarter che è esattamente quel che dice il nome: un quartiere abbastanza grande di Manchester centro gay friendly. Non è una denominazione convenzionale, pannelli del Comune con la dislocazione di alberghi, ristoranti e locali lo chiamano così, le strisce pedonali e i bordi dei muri sono colorati con l’arcobaleno. Un po’ come la vicina Chinatown a tema. Non ha l’aspetto di una piccola ghettizzazione, anzi, come non l’avrebbe Little Italy o Little Corea. Nel parco al centro del quartiere una statua ricorda Alan Turing, fenomenale matematico e padre della computazione dei moderni PC, vittima dello Stato inglese degli anni Cinquanta che considerava reato l’omosessualità. Che tempi assurdi, illegittimi, mai dar per scontato che siano passati definitivamente. Punirono per questioni di preferenze sessuali lo scienziato che aiutò il paese a decifrare il codice di Enigma dei nazisti, la statua di un uomo pacifico sta lì con la famosa mela a postumo e del tutto inutile risarcimento. In stazione, sempre per dire degli inglesi, dò un’occhiata alle riviste e vengo attratto dal settore riviste-che-parlano-di-treni.

Non sono monografie, sono mensili e bimestrali. Che quando uno pensa che sia stato detto tutto sui treni invece no, esce il nuovo numero. Ma mica basta, scherziamo? Nello scaffale sopra, i libri e le guide che si occupano di treni.

È vero che siamo in stazione ma è un negozio con riviste e giornali qualunque. Che sogno, per alcuni. Prendo il direttissimo delle Campagne per Bournemouth e scendo verso sud, Stoke-on-Trent e le sue ceramiche, Stafford, Birmingham, un’altra volta, Stratford-upon-Avon, sì, quella di Shakespeare, Coventry, quella coventrizzata, e vado a Oxford. Sarà un caso ma a pigliar la volta del sud appare il sole, prima volta da giorni.
Com’è andato il concerto ieri sera? Grazie per la domanda. Ricco di grazia com’è lei, Merchant, che riesce a cantare concetti gravi in modo lieve e poetico, ricco di umanità, così che sia un invito alla vita e non alla quiescenza. Oltre al fatto che è un’eccellente autrice e musicista. Comunque, a fianco a me è seduta una coppia, abbastanza giovane, vengono dalle Barbados e vivono nello Yorkshire, sono qui anche loro per Merchant. Chiacchieriamo. Lui a un certo punto si alza per andare in bagno e non torna per un po’, ci accorgiamo che vaga per la sala incapace di ritrovare il posto. Lei lo chiama senza successo, lui ha lo sguardo perso verso il nulla. Demenza, mi dice lei, resto impietrito e farfuglio qualche parola di dispiacere. Ed è lì che lei mi dice che di recente sono stati in Brasile, al mare, ora al concerto, non è mica un caso siano qui a sentire Merchant: “facciamo le cose nel modo più felice possibile”. Bam. Così ve la beccate dritta anche voi e fate i vostri conti con la vita.