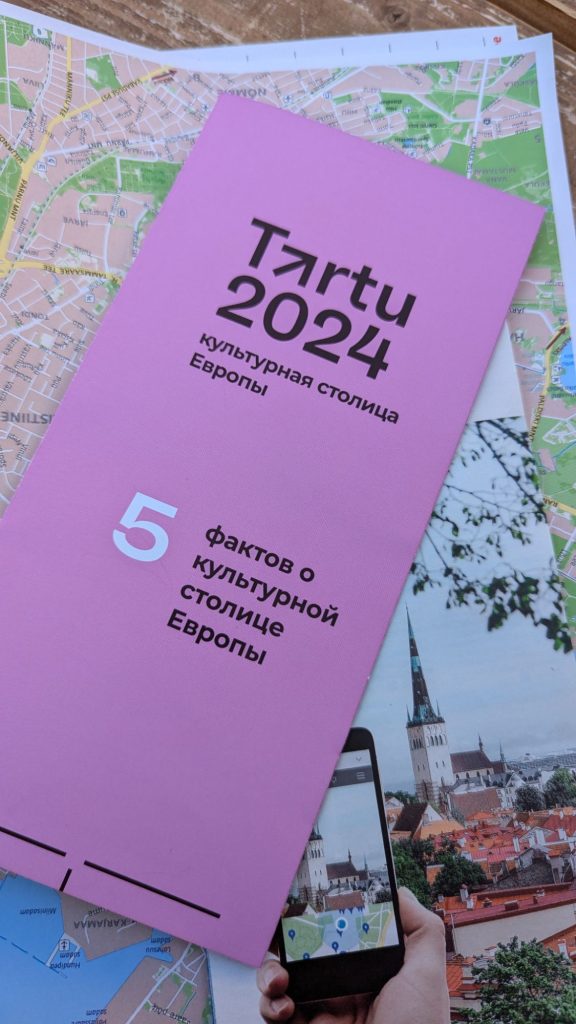Un classico dei paesi dell’est sono le biglietterie dei treni che vendono anche alimentari. Di solito presidiate da donnone arcigne di mezza età la cui espressione massima è il monosillabo gnnghrf che vendono variamente biglietti del treno, patatine e cioccolata, senza sentirsi in apparenza sminuite. Spaccare qualche faccia, magari, quello sì.

In questo caso c’è un supermercatino vero e proprio e un’elegante sala di attesa prospicente. E in questo caso la signora della biglietteria mastica l’inglese, cosa non solo non scontata ma solitamente improbabile. I binari sono a scartamento europeo e non russo, ben più larghi, non credo sia così in tutto il paese. Ma i treni li fanno comunque più larghi, comodi. E a differenza di altri paesi baltici, la Lettonia per esempio, la minoranza russa non è del tutto ostracizzata e a fianco di tutto quanto scritto in alfabeto latino si trova qua e là il cirillico, indicazioni, nomi, alcuni giornali. Alla fine, tra russi, bielorussi e ucraini sono il venticinque per cento della popolazione.

Che è, complessivamente, meno di un milione e mezzo di persone. Niente male. Al momento la stagione offre frutta grandiosa tra cui brillano lamponi e mirtilli, oltre che finferli. Non proprio a buon mercato, come quasi nulla qui – indice internazionale cappuccino: quattro euro, però ne vien via un tolotto – ma son ben spesi, enormi e succosi. Il pentimento poi.

Sul tabellone delle väljumised appare il mio treno, vado. Per l’inevitabile e solitamente umiliante spazio-civiltà, segnalo che sull’espresso su cui viaggio, unica categoria di treni esistente a parte il transbaltico europeo, non solo ci sono spazi per passeggini, biciclette e bagagli, prese elettriche, moquette ben tenuta, ma c’è anche la macchinetta, oltre che per valideeri il biglietto, per comprarlo proprio. Sul treno. E devo dirlo? Manco un telefono che suona, mai. Qualcuno che parla, raro e a bassa voce, ma suonare mai. MAI.

Signore, perché ci mescoli così male? Fuori piove, ci sono tredici gradi e le mie due ore di treno a guardare il paese fuori dal finestrino sono veramente un’ottima idea. In generale, oggi ancor di più. Bosco, bosco, Tapa, bosco, gruppo di case nel bosco, Rakvere, bosco, lago, bosco, Kiviöli, bosco. Mi torna la ricorrente tentazione di una casetta georgiana in legno in un villaggio baltico, tra la pineta e la spiaggia. Betulleta. Magari un mese, prima o poi. Fine del pezzo di costume.
Il treno ferma e non c’è un dove, oltre. La Narva, un bel fiumone, secondo nel golfo di Helsinki dopo la leggendaria Neva ghiacciata, scorre tra due alte rive e rupi e divide due imponenti fortezze, Narva e Ivangorod. Esse si fronteggiano da secoli, a partire dal dodicesimo secolo, quando il re danese ne fece il confine delle proprie conquiste, rispetto a ciò che vi era di là, un pericolo oscuro e costante, fossero russi o, in quel momento, l’Orda d’oro mongola. Poi furono l’ordine teutonico, gli svedesi, Nevskij e la Livonia, fu costruita anche l’altra fortezza e da allora si guardano per rive opposte quando la Russia o la Svezia recedevano. Lo storico ponte che univa le due sponde fu distrutto nella seconda guerra mondiale nella battaglia di Narva, una delle più terribili, che distrusse la città stessa, una volta famosa per il barocco tipico e chiamata ‘la perla del Baltico’. Niente più perle, niente più barocco. Dall’indipendenza, le due fortezze si guardano da Russia ed Estonia e il ponte che le unisce, chiamato con il tipico sarcasmo sovietico ‘dell’amicizia’, oggi fa da terra di nessuno. Come quello tra Uzbekistan e Afghanistan poco tempo fa, stesso nome e stesso tipo di amicizia.

L’amicizia oggi si percorre solo a piedi e dopo innumerevoli controlli. Se Istanbul è uno dei varchi aerei per la Russia, questo è uno di quelli pedonali, ancora un confine a piedi, coincidenze. Una galleria fatta di rete e filo spinato passa sul ponte e porta di qua e di là. Non essendo belligeranti UE e Russia, il confine non è chiuso. Una lunga fila di persone aspetta di entrare in Russia, la maggior parte ha l’aria di persone venute di qua con un trolley per riempirlo di cose. Ma non è detto, alcuni sembrano proprio turisti. E anche in uscita, in effetti.

È pur sempre una frontiera, non è che ci sia molto da far domande anche se una ragazza orientale mi dice sbrigativamente di essere in effetti una turista in uscita, andandosene prima che io menzioni la guerra. Mentre da un bastione osservo la fortezza di là, scorgo chiaramente un gruppo di visitatori su un mastio, hanno ombrelli e stanno ascoltando la spiegazione di una guida. Stanno certamente ascoltando le stesse cose che io ho appena letto, da prospettiva diversa, animati dal desiderio di sapere. Lo stesso mio desiderio, cosa che ci lega. Ma io di qua non posso andare di là e viceversa, io non posso visitare la loro fortezza e loro la mia, l’assurdità definitiva di un confine.


A seguito dell’indipendenza dell’Estonia nel 1920, al crollo dell’impero russo, e del trattato di Tartu, secondo l’articolo 122 della Costituzione estone il territorio di Ivangorod apparterrebbe ancora all’Estonia, visti però i rapporti tesi tra i due paesi la frontiera non è stata ancora riconosciuta dai russi. Stranamente. A parte le zone limitrofe al ponte, il resto del confine non è cintato, a parte i punti sensibili come la centrale elettrica, si può quindi nuotare o imbarchettarsi e andare di là. Però i cartelli multilingue parlano chiaro: quindici anni se si viene beccati di là senza visto. Ma poi chi andrebbe di là solo per vedere? Sano di mente, intendo, quindi non io, che scruto la riva facendo piani e sono venuto fin qui apposta per vedere di persona.

Un tizio pascola il gatto al guinzaglio e io è meglio mi trovi un caffè dove farmi asciugare e aspettare qualche ora il tardo treno per tornare a Tallinn, che il buio e il freschino e la pioggia incalzano.