quando c’era la cuccagna
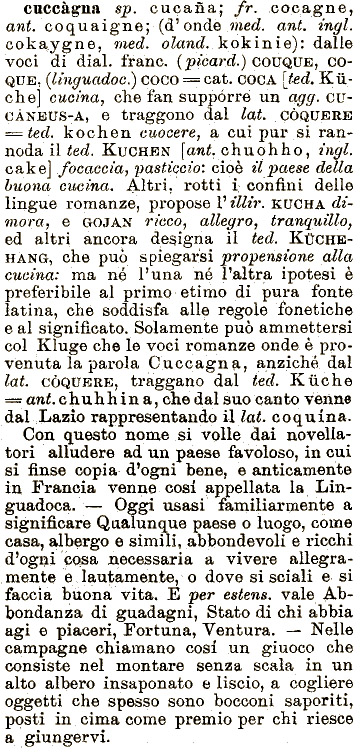 Ogni idea di abbondanza presuppone la mancanza cronica, altrimenti si è nel campo del superfluo e del vezzo tanto per: il salame o la coppa appesi in cima a un palo insaponato o ricoperto di grasso hanno significato solo e solamente se di norma il desco riserva polenta e castagne, quando va bene.
Ogni idea di abbondanza presuppone la mancanza cronica, altrimenti si è nel campo del superfluo e del vezzo tanto per: il salame o la coppa appesi in cima a un palo insaponato o ricoperto di grasso hanno significato solo e solamente se di norma il desco riserva polenta e castagne, quando va bene.
E’ tanto evidente quanto banale osservare che l’idea stessa di cuccagna, ovvero l’abbondanza alimentare a profusione nella quale bearsi e strafare, non ha alcun significato se la norma prevede visite quotidiane all’Esselunga a comprare i salamini nostrani o foresti a poco prezzo e a poco guadagno. Tutto ciò è definitivamente e irrimediabilmente perso. E con la sostanza, anche il concetto e le metafore che si accompagnavano alla cuccagna si sono diluiti e smarriti nella nostra abitudine alla sovrabbondanza.
Tanto meglio, sia chiaro, ché almeno si mangia diffusamente e collettivamente, ma la poesia delle cose – come sempre – qualcosina ci rimette. Se nel Cinquecento il momento più alto delle celebrazioni pasquali romane era il getto del maiale dal monte Testaccio – ovvero un emissario vaticano faceva precipitare alcuni maiali dalla collinetta romana, così che la popolazione potesse approfittarne – perché festa in generale significava festa per davvero, oggi il massimo della goduria festaiola è mangiare il salmone invece di un qualunque altro pesce simil-fresco, magari anche più pregiato.
Capirai che festa.
Ma non era così. E bisogna fare un certo qual sforzo di immaginazione per comprendere la gioia e la fantasia ingorda che un lauto pasto, inaspettato, sapeva regalare, e figuriamoci se un panettone ipermandorlato può oggi insufflare simili suggestioni. Sforzandosi, però, è possibile intuire e ricostruire, leggendo ciò che fu e non è più: memorabile a questo proposito, e a proposito di cuccagna, un brano magistrale di Teofilo Folengo, uno dei due maestri immortali di trivigante, nel primo libro del Baldus. Ecco la sua descrizione del paese di Cuccagna:
Abbiamo scalato laggiù montagne fatte di formaggio tenero, duro e mezzano. (…) Là scorrono a valle profondi fiumi di brodo, che fanno un lago di zuppa, un mare di sugo. Vi si vedono andare e venire zattere, barche, grippi maneggevoli tutti fatti di pasta per torte; in essi le Muse manovrano lacci e reti, reti di salsicce, intrecciate di trippe di vitello e pescano gnocchi, frittelle e gialle polpette. (…) Ci sono là pendii di burro fresco e tenero, sui quali fumano fino alle nubi cento caldaie piene di casoncelli, di macaroni e di tagliatelle. [Le Muse] grattugiano in continuazione formaggio con grattugie forate. Alcune si dan da fare a preparare gnocchi teneri che rotolano in frotta per il formaggio e, ruzzolando dalla cima del monte fino al basso, diventano come botti dalla grossa pancia. (…) [Le Muse], dee grasse, le ninfe che colano unto.
La prossima volta, la cuccagna di Panurge. Bei tempi per la fantasia.
